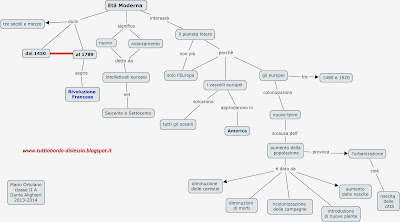Matteo ha scritto:
Buongiorno professoressa,
le vorrei gentilmente chiedere aiuto riguardo la risoluzione di questo problema con la normalità.
Calcolare la pressione osmotica a 25 °C di una soluzione ottenuta mescolando 400 mL di una soluzione di idrossido di calcio 0,10 N con 200 mL di una soluzione di acido cloridrico 0,20 N.
Inoltre indicare lo schema di reazione e il pH della soluzione ottenuta.
Grazie.
La risoluzione è questa:
Lo schema della reazione che avviene unendo la soluzione di idrossido di calcio e quella di acido cloridrico è
Ca(OH)2(aq) + HCl(aq) → H2O(l) + Ca2+(aq) + Cl-(aq)
Poiché la pressione osmotica della soluzione dipende dal numero di particelle di soluto (in questo caso ioni) che essa contiene, è necessario determinare se la reazione di neutralizzazione è completa, oppure se uno dei due reagenti è in eccesso. La stessa informazione è utile poi per determinare il pH finale.
Per quanto riguarda la normalità, N, tieni presente quanto segue:
- è il numero di equivalenti di soluto disciolti in 1 L di soluzione
- un equivalente è una quantità di sostanza portatrice di una mole di carica elettrica positiva o di una mole di carica elettrica negativa; nel caso di HCl, equivalente e mole corrispondono; nel caso di Ca(OH)2 una mole contiene due equivalenti, dato che ogni mole di Ca(OH)2 libera due moli di ioni OH-; anche una mole di CaCl2 contiene due equivalenti, dato che libera due moli di ioni Cl-
- un equivalente di sostanza si combina sempre con un equivalente di qualsiasi altra sostanza.
Per quanto riguarda la pressione osmotica, la relazione che la definisce quando in soluzione è contenuto un sale come soluto, cioè un elettrolita forte, è
π = nRT·i / V
in cui il coefficiente i corrisponde al numero di moli di ioni generati da una mole di elettrolita forte. Poiché il sale CaCl2 è dissociato secondo l’equazione
CaCl2 → Ca2+(aq) + 2 Cl-(aq)
il coefficiente i corrisponde a 3.
I calcoli in dettaglio sono questi:
neq Ca(OH)2 = N·V = 0,10 eq/L·0,400 L = 4,0·10-2 eq
neq HCl = N·V = 0,20 eq/L·0,200 L = 4,0·10-2 eq
neq Ca(OH)2 = neq HCl la neutralizzazione è completa
neq CaCl2 = 4,0·10-2 eq
n CaCl2 = neq CaCl2 / 2 eq/mol = 4,0·10-2 eq / 2 eq/mol = 2,0·10-2 mol
Vsoluzione = VHCl + VCa(OH)2 = (0,400 + 0,200) L = 0,600 L
π CaCl2 = nRT·i /V = 2,0·10-2 mol · 0,0821 L·atm/(mol·K) · 298 K· 3 / 0,600 L = 2,4 atm
Essendo acido e base miscelati in quantità equivalente, nella soluzione finale c’è soltanto il sale cloruro di calcio; poiché l’acido e la base da cui esso deriva sono entrambi forti, il sale non dà reazione di idrolisi per cui il pH della soluzione è 7.
In conclusione, la pressione osmotica a 25 °C della soluzione ottenuta mescolando 400 mL di idrossido di calcio 0,10 N con 200 mL di acido cloridrico 0,20 N vale 2,4 atm, mentre il pH della soluzione finale è 7.